Le forme della trasmissione del sapere in Arabia al tempo del Profeta Muhammad
![]()
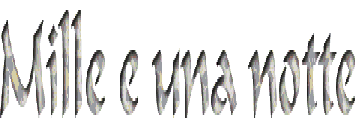
Le mille e una notte Storia delle tre mele
Storia della dama trucidata e del suo giovane marito
Raccolta di novelle e fiabe della Letteratura Araba
Le mille e una notte - Introduzione
![]()
LE MILLE E UNA NOTTE - STORIA DEL PICCOLO GOBBO
C'era una volta a Gasgar, ai confini estremi della grande Tartaria, un sarto, il quale aveva una moglie bellissima, che egli amava assai e dalla quale era molto amato. Un giorno, mentre lavorava, un piccolo gobbetto venne a sedersi sull'ingresso della sua bottega, e si mise a cantare, suonando un tamburello. Il sarto ebbe gran piacere nell'udirlo e decise di condurlo nella sua casa per divertire sua moglie.«Con le sue piacevoli canzoni», diceva, «questa sera ci divertirà entrambi.»
Gliene fece perciò la proposta, e avendola il gobbo accettata, chiuse la bottega e lo condusse a casa.
Appena arrivati, la moglie del sarto, essendo l'ora di cena, portò in tavola un buon piatto di pesce.
Nel mangiare, il gobbo, per sua disgrazia, inghiottì una grossa lisca, per cui in pochi momenti ... ccontinua a leggere
STORIA DEL MERCANTE CRISTIANO
Sire, prima di impegnarmi nel racconto in questione, vi dirò che io sono uno straniero nato al Cairo d'Egitto, di religione copta. Mio padre era sensale e aveva acquistato ricchezze considerevoli. Io seguii il suo esempio, e abbracciai la sua professione. Trovandomi un giorno al Cairo nel mercato delle granaglie, un giovane mercante molto bello ed elegante, montato sopra un asino, mi fermò. Mi salutò, e aprendo un fazzoletto, in cui teneva una certa quantità di grani di sesamo:«Quanto vale», mi disse, «una gran misura di sesamo di questa qualità?».
Esaminai i grani mostratimi e risposi che valevano ... continua a leggere
![]()
![]()
STORIA DEL MANCINO
Sappiate - mi disse - che sono nativo di Bagdàd, figlio di un padre ricco e dei più distinti della città, per nascita e per grado.Come fui giunto all'età di dodici anni, frequentai persone che avevano viaggiato e che dicevano grandi meraviglie dell'Egitto, e particolarmente del Cairo. I loro discorsi mi fecero una forte impressione, e desiderai vivamente di venirvi, ma mio padre era ancora vivo e non me ne avrebbe mai dato il permesso.
Quando morì restai padrone assoluto di me stesso e risolvetti di venire al Cairo. Impiegai una gran somma di danaro in molte specie di stoffe finissime di Bagdàd e di Mossul e mi rimisi ... continua a leggere
STORIA DEL SOVRINTENDENTE
Sire, una persona di qualità m'invitò ieri alle nozze di una delle sue figlie. Non mancai di andarvi all'ora fissata e mi trovai in un'assemblea di dottori, d'ufficiali di giustizia e di altre persone più distinte di questa città. Dopo la cerimonia fu apparecchiato un banchetto magnifico; tutti si misero a tavola e ognuno trovò da mangiare i suoi cibi preferiti. C'era fra l'altro un antipasto eccellente, condito con l'aglio, che era così buono che tutti ne volevano. Osservammo che un invitato, tra gli altri, non ne prendeva, sebbene avesse il piatto proprio davanti. Allora lo esortammo a seguire il nostro esempio.Ci scongiurò di non insistere a questo proposito.
«Mi guarderei bene», ci disse, «dal gustare un intingolo in cui vi sia dell'aglio; non ho dimenticato quello che mi costò l'averne assaggiato una volta.»
Lo pregammo di narrarci il fatto: ma il padrone di casa, senza dargli tempo di rispondere, gli disse:
«E così che fate onore alla mia tavola? Questo intingolo è delicato; non pretenderete ... continua a leggere
STORIA DELL'INVITATO
Sappiate, signori miei, che sotto il regno del califfo Harùn ar-Rashìd, mio padre viveva a Bagdàd, dove sono nato, e passava per uno dei più ricchi mercanti della città. Ma poiché era un uomo dedito ai piaceri e alla crapula, trascurava i suoi affari, e invece di ereditare grandi ricchezze, alla sua morte ebbi bisogno di fare ogni economia per saldare i debiti lasciati da lui. Giunsi finalmente a pagarli tutti, e impegnando ogni cura, riuscii a farmi una piccola fortuna.Una mattina, nell'aprire la mia bottega, una dama, che cavalcava una mula, ed era accompagnata da un eunuco e da due schiavi, passò vicino alla mia porta e si fermò. Pose il piede a terra con l'aiuto dell'eunuco, che le diede la mano, dicendole:
«Signora, vi avevo detto che era troppo presto; vedete che non c'è ancora nessuno al Bazar, e se aveste voluto credermi, vi sareste risparmiata ... continua a leggere
STORIA DEL MEDICO EBREO
Sire, quando studiavo medicina, e cominciavo ad esercitare quest'arte con qualche reputazione, uno schiavo venne a cercarmi, perché andassi a visitare un infermo dal governatore della città. Vi andai e venni introdotto in una camera, dove trovai un uomo di età giovanile e di bellissimo aspetto, ma molto abbattuto. Lo salutai, sedendomi vicino a lui, ma lui non rispose alla mia cortesia. Invece mi fece cenno con gli occhi, per farmi capire che udiva quello che dicevo e che mi era grato.«Signore», gli dissi, «vi prego di porgermi la mano, perché vi senta il polso.»
Invece di darmi la mano destra, mi presentò la sinistra; ne restai estremamente sorpreso.
«Questo», dissi fra me stesso, «è un grande ignorante, e non sa che si deve presentare al medico la destra e non la sinistra.»
Tuttavia gli tastai il polso, e, dopo avere scritto una ricetta, me ne andai.
Continuai le mie visite per nove giorni, e ogni qual volta volli tastargli il polso, mi presentava la mano sinistra. Al decimo giorno mi parve che stesse bene, e gli dissi che ormai ... continua a leggere
STORIA DEL GIOVANE DI MOSSUL
Sono nativo di Mossul, e la mia famiglia è una delle più considerevoli della città. Mio padre era il maggiore di dieci figli, che erano tutti vivi e maritati quando mio nonno morì. Ma di questo gran numero di fratelli, mio padre fu il solo che ebbe figli.Ebbe gran cura della mia educazione e mi fece imparare tutto ciò che un fanciullo della mia condizione deve sapere.
Ero già abbastanza grande e cominciavo a frequentare la società, quando un venerdì mi trovai alla preghiera del mezzogiorno con mio padre ed i miei zii, nella gran moschea di Mossul.
Dopo la preghiera uscirono tutti, fuorché mio padre e i miei zii che si sedettero sopra il tappeto disteso per tutta la moschea. Mi sedetti con loro e, conversando di molte cose, il discorso insensibilmente andò a cadere sopra i viaggi. Essi vantarono le bellezze e le singolarità di certi regni ... continua a leggere
STORIA DEL SARTO
Sire, un cittadino di questa città mi fece l'onore, due giorni or sono, d'invitarmi a un banchetto che offriva ai suoi amici. Vi andai presto, e vi trovai circa venti persone, che aspettavano il padrone di casa, che era uscito per qualche affare.Presto lo vedemmo arrivare accompagnato da un giovane forestiero, vestito con molta eleganza, molto ben fatto, ma zoppo.
Ci alzammo tutti per far onore al padrone di casa, e pregammo il giovane di sedersi accanto a noi.
Egli stava per farlo, quando, vedendo un barbiere che faceva parte della nostra compagnia, si tirò indietro con sdegno, e disse che voleva uscire.
Il padrone di casa sorpreso del suo gesto, lo fermò.
«Dove andate?», gli disse. «Io vi conduco con me perché partecipiate a un banchetto che offro ai miei amici, e appena entrato volete uscire?»
«Signore», rispose il giovane, «in nome di Maometto vi supplico di non trattenermi, poiché non posso vedere senza orrore questo abominevole barbiere, il quale, benché nato in un paese ove tutti sono bianchi, assomiglia ad un etiope, e ha l'anima ancora ... continua a leggere
![]()
![]()
STORIA DEL GIOVANE ZOPPO
Mio padre aveva nella città di Bagdàd un grado così alto che avrebbe potuto aspirare alle principali cariche, ma egli preferì sempre una vita tranquilla. Non ebbe altri figli all'infuori di me e quando morì io ero già in età di poter disporre delle grandi ricchezze che mi aveva lasciato. Non le dissipai pazzamente, ma ne feci anzi buon uso così da meritarmi la stima generale.Non avevo ancora provato alcuna passione e non ero sensibile all'amore, anzi, confesso, con mio rossore, che sfuggivo a bella posta il contatto delle donne.
Un giorno, mentre mi trovavo in una strada, vidi venirmi incontro una gran turba di donne: per non incontrarle presi una strada traversa, e mi sedetti su un banco vicino a una porta. Stavo di fronte a una finestra, dove c'era un vaso di fiori bellissimi, su cui tenevo fissi gli sguardi, quando la finestra ... continua a leggere
STORIA DEL BARBIERE
Sotto il regno del califfo al-Mùstansir Billah - cominciò a dire - principe famoso per la sua immensa liberalità verso i poveri, dieci ladri infestavano le strade dei dintorni di Bagdàd, e da gran tempo compivano furti e crudeltà inaudite.Il califfo, avvertito di tale situazione, fece venire qualche giorno prima della solennità del Bairam, il luogotenente criminale e gli ordinò, pena la morte, di condurgli tutti e dieci i ladri.
Il luogotenente criminale prese le sue misure e mandò tanti uomini per la campagna, che i dieci ladri furono arrestati il giorno stesso del Bairam. Passeggiavo sulla sponda del Tigri, quando vidi dieci uomini riccamente vestiti, che si imbarcavano su un battello. Senza badare alle guardie che li accompagnavano, e credendo fossero persone che andassero a divertirsi e a solennizzare la festa con banchetti, salii sul battello con loro, sperando che si sarebbero compiaciuti di tollerarmi nella loro compagnia.
Varcammo il Tigri, e giungemmo davanti al palazzo del califfo. Ebbi appena il tempo di rientrare in me stesso ed accorgermi del mio errore. Scendendo dal battello fummo circondati ... continua a leggere
STORIA DEL PRIMO FRATELLO GOBBO
Sire - gli dissi - il mio fratello maggiore, chiamato al Baqbùq era gobbo, ed era sarto di professione. Prese in affitto una bottega di fronte a un mulino, ma poiché conosceva poco il suo lavoro, campava la vita con grandi stenti.Il mugnaio di fronte, al contrario, viveva comodamente, e aveva una moglie bella, anzi bellissima.
Un giorno mio fratello, mentre lavorava nella sua bottega, alzò il capo e vide alla finestra del mulino la mugnaia, che guardava nella strada. La trovò tanto bella che se ne innamorò.
In quanto alla mugnaia, non si accorse neppure di lui e poco dopo chiuse la finestra. Per tutto il giorno non comparve più. Intanto il povero sarto non faceva che alzare il capo e gli occhi verso il mulino, così che lavorando si punse le dita più di una volta ed il suo lavoro di quel giorno non fu proprio molto ben fatto. Alla sera, quando bisognò chiudere bottega, ebbe gran pena a decidersi; perché sperava di rivedere la bella mugnaia. Ma finalmente fu obbligato a chiuderla, e a ritirarsi nella sua ... continua a leggere
STORIA DEL SECONDO FRATELLO SDENTATO
Il mio secondo fratello, chiamato Bakbarah lo sdentato, camminando un giorno per la città incontrò una vecchia in una strada remota. Ella lo fermò e gli parlò:«Ho una parola da dirvi; vi prego di fermarvi un momento».
Egli le domandò di che si trattasse.
«Se avete tempo di venire con me», riprese lei, «vi condurrò in un palazzo magnifico, dove vedrete una dama più bella del sole che vi accoglierà con molto piacere e vi offrirà la colazione con del vino eccellente.»
«Ciò che mi dite è poi vero?», replicò mio fratello.
«Io non sono una bugiarda!», ribatté la vecchia. «Ma ascoltate quel che esigo
da voi. Voi dovete essere savio, parlare poco, e avere una cortesia infinita.»
Bakbarah avendo accettato queste condizioni, si incamminò con la vecchia.
Giunsero alla porta di un gran palazzo, dove c'erano molti ufficiali e servitori. Alcuni volevano fermare mio fratello: ma non appena la vecchia ebbe parlato ... continua a leggere
STORIA DEL TERZO FRATELLO CIECO
Gran principe dei credenti - egli disse al califfo - il mio terzo fratello, chiamato Baqbaq, era cieco; e il suo destino lo aveva ridotto a vivere mendicando, così che egli se ne andava di porta in porta a chiedere l'elemosina. Aveva una gran pratica di camminare solo per le strade, e non aveva bisogno di nessuno con sé. Era solito bussare alle porte, e non rispondeva prima che gli fosse aperto.Un giorno bussò a una porta e il padrone di casa, che era solo, domandò:
«Chi è?».
Mio fratello non rispose e bussò una seconda volta.
Il padrone della casa domandò di nuovo chi bussasse, ma nessuno gli rispose.
Egli discese, aprì, e domandò a mio fratello che volesse.
«Che mi diate qualche cosa per elemosina», gli disse Baqbaq.
«Voi siete cieco, mi pare», disse il padrone di casa.
«Ohimè! questo è purtroppo vero», rispose mio fratello.
«Stendete la mano», gli disse il padrone.
Mio fratello gliela presentò, credendo che volesse fargli l'elemosina, ma il padrone ... continua a leggere
STORIA DEL QUARTO FRATELLO GUERCIO
Il nome del mio quarto fratello era al-Kawz ed egli diventò guercio in seguito alla storia che ho l'onore di narrare alla maestà vostra.Egli era macellaio e aveva un talento speciale per allevare montoni e allenarli al combattimento. In questo modo ottenne l'amicizia dei signori più importanti della città perché essi, provando gran piacere in simili spettacoli, tengono a questo scopo dei montoni. Inoltre era molto stimato perché nel suo negozio aveva sempre carne della migliore qualità: infatti era molto ricco e non risparmiava nell'acquisto.
Un giorno, in cui se ne stava nella sua bottega, un vecchio dalla barba bianca venne a compare sei libbre di carne; gli diede il denaro richiesto e se ne andò. Mio fratello trovò il denaro del vecchio così bello, così lucido e così ben coniato, che lo mise ... continua a leggere
STORIA DEL QUINTO FRATELLO DALLE ORECCHIE TAGLIATE
Ho l'onore di dirvi che il mio quinto fratello si chiama al-Ashshar e la sua storia è questa:Finché visse nostro padre, al-Ashshar fu l'uomo più pigro del mondo. Invece di lavorare per guadagnarsi la vita, non aveva vergogna di chiedere l'elemosina. Nostro padre morì molto vecchio lasciandoci in tutto settecento dirham. Li dividemmo in parti eguali fra noi, così ciascuno ne ebbe cento, al-Ashshar, che non aveva mai posseduto tanto denaro in una volta si trovò molto imbarazzato su come impiegarlo. Pensò a lungo tra sé a tale proposito, e decise finalmente d'impiegarlo in bicchieri, bottiglie e altri oggetti di vetro, che andò a comprare da un ricco mercante.
Pose tutto in una grande cesta, e scelse una piccola bottega, dove si sedette con la cesta davanti a sé e la schiena appoggiata al muro, in attesa degli avventori.
In questa posizione con gli occhi fissi sul suo canestro si mise ... continua a leggere
![]()
Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.
Guadagnare acquistando online.
![]()
STORIA DEL FRATELLO DALLE LABBRA TAGLIATE
Il mio sesto fratello si chiamava Shaquàliq, dalle labbra tagliate. Egli dapprima si industriò molto bene con i cento dirham avuti in eredità, come gli altri fratelli: ma un rovescio di fortuna lo ridusse alla necessità di domandare l'elemosina. Gli riusciva benissimo, e soprattutto cercava di procurarsi la possibilità di entrare nelle grandi abitazioni con l'aiuto dei servi, per poter poi giungere fino ai padroni e muovere la loro compassione.Un giorno, passando davanti a un palazzo magnifico, la cui porta aperta lasciava vedere un cortile spaziosissimo brulicante di domestici, si avvicinò a uno di essi e gli domandò a chi appartenesse quel palazzo.
«Buon uomo», gli rispose il servo, «da dove venite, per farmi questa domanda? Quanto vedete dovrebbe farvi capire che questo appartiene a un Barmecida.»
Mio fratello, cui la generosità dei Barmecidi era ben nota, si rivolse ai
portinai, ce n'era infatti più d'uno, e li pregò di fargli l'elemosina.
«Entrate», gli risposero, «nessuno ve lo impedisce, e rivolgetevi al padrone,
che vi accontenterà.»
Mio fratello, non aspettandosi tanta cortesia, ringraziò ... continua a leggere
![]()
1 - LE FORME DELLA TRASMISSIONE DEL SAPERE IN ARABIA AL TEMPO DEL PROFETA MUHAMMAD
A lungo si è discusso, ed ancora si discute, se la poesia araba preislamica sia stata realmente orale o meno, e più in generale se la società dell'Arabia preislamica in cui nacque il profeta Muhammad* (analfabeta, secondo la tradizione), fosse davvero una società senza scrittura. Sappiamo ad esempio da al-Balâdhurî (m. 892) [De Goeje 1866: 473-4] che alla Mecca ai tempi in cui nacque il profeta vi erano 17 persone che sapevano leggere e scrivere. Sono tante o sono poche?
Numerose testimonianze danno forza ai sostenitori dell'esistenza di una "società delle lettere" preislamica. La grande produzione di poesia da un lato - di cui sono testimoni i corpora a noi giunti, e la sterminata mole di iscrizioni e graffiti rinvenuti in tutta la Penisola dall'altro (circa 12.000 in sudarabico, decine di migliaia in nordarabico, una decina in arabo prima del 622, ma subito a migliaia nel primo secolo dell'egira, e svariate migliaia in aramaico), potrebbero far pensare - addirittura - ad una società di grafomani. Tuttavia, fa notare Christian J. Robin [2001: 560 e ss.], di tutti i testi pervenutici non ve n'è uno che abbia valore letterario in senso stretto: né poesia, né inni religiosi, né mitologia, né storia, né narrativa, ma solo testi legali, celebrativi, amministrativi, firme, tutt'al più epitaffi (seppure con un'unica ma importantissima eccezione).
* L'unico testo strettamente letterario è il cosiddetto "Inno di Qanya". Si tratta di un testo graffito (un inno alla Dea del Sole) di 27 versi scritti su una roccia nei pressi di Qanya (Yemen) in caratteri sudarabici, ma in una lingua ancora sconosciuta (probabilmente himyaritico, o un dialetto nordarabico), databile alla fine del I sec. d.C.. Il testo è pubblicato in Y. `Abdallâh [1988] e da lui tradotto in A.de Maigret e A.Avanzini [2000:157]. Sebbene la sua interpretazione e traduzione sia tutt'altro che chiara, è palese il fatto che sia in rima, dal momento che ciascun verso termina con le stesse consonanti hk, quindi addirittura una rima più complicata del normale. Il fatto che questa sia <<verosimilmente la più antica poesia monorima della letteratura universale>> [secondo le parole di Christian J. Robin "Una civiltà della scrittura", in A.de Maigret e A.Avanzini 2000: 125], garantisce sulle origini autonome della rima in Arabia, ma non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una produzione scritta di tipo letterario su vasta scala.
Ed anche quando le fonti indirette menzionano la scrittura, si tratta sempre di lettere, missive diplomatiche, accordi politico-commerciali, iscrizioni. La scrittura nell'Arabia preislamica, dunque, sembra essere utilizzata solo per scopi pratici, per fissare delle norme oppure per trasmettere e diffondere un sapere tecnico e forse politico, ma non storico, non letterario, non religioso. Questi saperi, di cui ci accingiamo ad analizzare le forme, sembrano essere fondati - invece - su un tipo di trasmissione orale.
* Tale concetto era stato felicemente espresso già nel IX secolo dal poligrafo al-Jâhiz (m. 868):
<<Ogni civiltà si prefigge di preservare le proprie gesta e di consolidare le proprie imprese, in qualche modo e in qualche forma. Gli Arabi si sono adoperati per renderle eterne proprio attraverso la poesia in metrica e il parlare rimato. È questo il loro archivio [diwân]. Al contrario, le civiltà non arabe hanno scelto di fissarle nei monumenti>>. (Jâhiz I, 71)
Come rilevato dagli studi di J.T.Monroe [1972] e M.Zwettler [1978], infatti, la poesia preislamica (le cui più antiche testimonianze risalgono agli inizi del VI sec.) presenta tutti gli elementi tecnici e mnemotecnici propri della poesia orale riscontrati in altre tradizioni e cioè:
- metrica e prosodia atta ad essere cantata o salmodiata, corroborata da un sistema di accentazione musicale, e non tonico, della lingua;
- uso di formule: ripetizioni di parole o gruppi di parole in medesima posizione all'interno del verso;
- strutture formulari di tipo sintattico: coniugazione o declinazione di elementi simili nella stessa posizione di una frase, posizione ricorrente di un morfema in un verso, costante cambio di posizione sintattica di due elementi in funzione prosodica;
- strutture formulari di tipo lessicale, dove la sostituzione di un termine della formula produce un nuovo sintagma formulare.
LA RIMA
Vi sono almeno altri due elementi intrinseci, peculiari della lingua e della poesia araba, funzionali alla trasmissione orale del corpus letterario:
- La morfologia caratteristica dell'arabo;
- La rima.
Morfologia. In arabo le radici, che costituiscono il semantema e sono in massima parte costituite da tre consonanti, si innestano su schemi morfologici a vocalizzazione e sillabazione fissa, costituenti il morfema. Ad esempio: il morfema del participio attivo (e quindi l'agente) segue lo schema CâCiC e il participio passivo (e quindi del prodotto di un'azione) segue invece lo schema maCCûC. Dunque, tutte le parole formate dalle varie radici su questi due schemi avranno simile funzione logica, oltre che una struttura sillabica costante. All'interno della struttura metrico-prosodica del verso, la invariabilità sillabica - come è facilmente intuibile - risulta estremamente utile sia per chi debba comporre estemporaneamente, sia per chi debba memorizzare e ripetere.
Rima. A differenza della poesia classica greca e latina, tutta, ma proprio tutta, la poesia araba classica è in rima, anzi in monorima, e spesso le poesie prendono il titolo proprio dalla consonante con la quale rimano. La rima (qâfiya) consiste nell'identità consonantica e vocalica dell'ultimo piede del verso che prende il nome di rawî. Generalmente, nel genere della qasîda, ossia la forma principe della poesia araba, rimano fra loro anche i primi due emistichi.
La rima non è esclusiva della poesia. Anche gli "indovini" preislamici, o più genericamente quelli che possiamo definire come "i portatori del discorso religioso" (kâhin), usano un "parlare rimato" che assolve a funzioni mnemoniche: il saj` (prosa rimata).
SHI`R
Gli elementi tipici delle manifestazioni culturali e folkloristiche trasmesse oralmente (metrica rigida, rima, brevità del testo, formulari, scarso uso dell'enjambement, ecc.) sono funzionali alla loro interpretazione drammatica. Il testo orale è destinato ad essere performato. Anche la poesia (shi`r) preislamica è principalmente una forma di intrattenimento e il poeta (shâ`ir, letteralmente "colui che percepisce, colui che è sensibile") è sostanzialmente un "perfomer" [Zwettler 1978: 26 e ss.; Monroe 1972: 12 e ss.]. Il poeta deve padroneggiare la lingua, la metrica, la prosodia, e tutte le tecniche di composizione orale, acquisendo e affinando un proprio patrimonio formulare - attinto dal fondo tradizionale comune - che sia flessibile e adattabile alle diverse situazioni performative. La sua "bravura", dunque, risiede soprattutto nella capacità di improvvisazione. In altre parole come un musicista inizia la sua improvvisazione con le scale che tutti conoscono, aggiungendo nel corso della performance le sue variazioni, il poeta inserisca i suoi particolari accenti su uno spartito che l'uditorio trova familiare (usatissime formule iniziali sono <<qifâ wa-nabki>>, "fermatevi e piangiamo insieme"; <<li-man talâlun>>, "di chi sono le vestigia di accampamento") e attraverso uno schema narrativo precostituito, seppure aperto. Il tutto finalizzato a colpire l'uditorio (dare emozioni, appunto).
RIWÂYA
Nell'Arabia preislamica il patrimonio storico-letterario, ossia la produzione dei poeti e degli indovini, è custodito nella memoria del trasmettitore orale: il râwî (plur. ruwâ), un vero e proprio professionista delle tecniche mnemoniche. Il materiale che il râwî acquisisce e "trasmette" è dotato di strutture formali funzionali alla trasmissione del sapere. Infatti, se tutti i componenti di una tribù possono in qualche modo dirsi trasmettitori "amatoriali" in quanto tutti, nel momento in cui vogliono raccontare la propria storia e la propria mitologia, possono citare qualche verso in maniera più o meno fedele a come lo hanno udito, il râwî - figura semi-istituzionale all'interno di ciascuna tribù, quasi il depositario della memoria storica dell'orgoglio tribale - garantisce una "trasmissione perfetta" grazie all'impiego di tutte le sue abilità e tecniche.
* Almeno fino al VII sec., ossia fino a quando la poesia rimane circoscritta la mondo beduino, il râwî "performa" il suo repertorio così come lo ha appreso. Il processo di apprendistato e memorizzazione del râwî è in certo modo diverso da quello del poeta, dal momento che quest'ultimo non ha nemmeno bisogno di imparare a memoria le proprie poesie. Eppure <<non si può sostenere che la "memorizzazione" attraverso la lettura o l'ascolto di un "testo fissato" fosse, per un professionista allenato ed immerso in una tradizione di poesia resa oralmente, lo stesso che "memorizzazione così come lo si apprende" (memorization as we know it). Al tempo in cui non esisteva una netta distinzione fra parola scritta e parola parlata (in particolare nel caso della poesia, che presuppone comunque un uditorio), sarebbe difficile sostenere che l'esposizione approfondita di un tale performer a poemi orali come a poemi composti per essere performati oralmente non gli abbia fornito una sensibilità della composizione attraverso gli strumenti di formule "orali", temi e via dicendo, analoghi, se non identici, a quelli dello stesso poeta orale>> [Zwettler 1978: 25]. Sono dunque le strutture compositive intrinseche della poesia a diventare strumenti mnemotecnici atti alla propria trasmissione.
La sua figura assolve a diverse funzioni: è al tempo stesso rapsodo e trasmettitore, cantastorie e filologo, impara a memoria le poesie, le raccoglie e le interpreta in pubblico; dovendo approfondire anche le tecniche di composizione, per soddisfare al meglio le esigenze dell'auditorio, può a sua volta produrre nuove poesie. Infine le spiega, raccontando i contesti e le circostanze storiche o leggendarie a cui esse sono legate.
2 - I "NUOVI GENERI" DELLA LETTERATURA ORALE
Nel 612 debutta in Arabia la missione profetica (nubuwwa) di Muhammad , che consiste nell'annunciare agli Arabi la "parola divina". Il Profeta (nabî, "nunzio") può sembrare un poeta, per le sue capacità performative, può sembrare un indovino, per il fatto che recita in prosa rimata, può sembrare un râwî , per il fatto che ripete qualcosa che gli è stato insegnato, ma non porta poesia né oracoli, bensì annuncia la "parola divina", si esprime nelle forme che Iddio gli indica, anzi è Iddio stesso che parla per sua bocca. Infatti, a differenza del Dio biblico o cristiano, il Dio musulmano non fa discendere le sue tavole della Legge, vergandole di sua mano, né ispira a qualcuno la scrittura di un testo sacro. Rivela invece "in un sol colpo" al suo Inviato, per mezzo dell'Arcangelo Gabriele, una "recitazione" o "lettura" - qur'ân (Corano, cioè) - durante una "notte benedetta"; un "discorso" che deve essere riportato agli Arabi nella forma esatta in cui è "disceso".
Il Qur'ân, dunque, è un atto orale e performativo la cui modalità di trasmissione sembra ricalcare quella della letteratura orale ma, al tempo stesso, rappresenta un nuovo genere letterario. Esso si distingue, fra l'altro, per un uso fortemente innovativo del linguaggio: propone il dogma di una lingua "perfetta" e "unificata" che superi la Babele tribale preislamica, disseminata di varianti dialettali e divergenze lessicali.
* La lingua proposta è però sostanzialmente quella della poesia, ossia la lingua aulica ed eloquente (fushâ) che non lascia spazio ad equivoci. I suoi caratteri innovativi, individuabili sul piano stilistico-lessicale in funzione della novità del messaggio, portano ulteriormente avanti il processo di unificazione linguistica e al tempo stesso ampliano le potenzialità comunicative dell'arabo.
Quali sono le conseguenze dell'introduzione del Corano?
NUBUWWA
`Antara, uno dei più antichi poeti preislamici il cui nome è giunto fino a noi, apre una famosa qasîda chiedendosi:
i poeti hanno lasciato ancora qualcosa da dire? e tu hai riconosciuto infine il luogo ove dimorava l'amata?
Questi versi, come osserva Abdalfattah Kilito [1988c: 5 e ss.], pongono l'ode al termine di una tradizione narrativa che ha sempre cercato invano di rispondere a domande simili. Essi riagganciano la memoria dell'auditorio a qualcosa di noto e, se autorizzano il poeta a dire qualcosa che non è ancora stato detto, pongono la poesia stessa alla fine di un percorso lungo il quale si sono sovrapposte le voci di anonimi performer e trasmettitori, ciascuno dei quali procedeva sulle tracce dell'altro. In questo meccanismo, comune a tutta la produzione poetica preislamica, la questione dell'autenticità, dell'attribuzione, del plagio e della falsificazione - in una parola dell'autorialità - ha dunque un'importanza relativa rispetto al bagaglio formulare della poesia orale, che è il vero patrimonio della collettività.
Solo quando sulla scena irrompe la profezia, si pone il problema dell'autenticità, introducendo uno degli elementi fondante dell'intero costrutto culturale arabo islamico: l'autore. La figura dell'autore/discorso autorevole acquista infatti notevole importanza nell'Islâm poiché è Iddio stesso a ricoprire per antonomasia questo ruolo: egli è il primo "firmatario" di un'opera - il Corano - la prima entità individuale autoriale-autorevole,
* Uno degli attributi di Dio - nonché uno dei suoi santissimi 99 nomi - è "al-matîn" ovvero "il Saldo" (Cor. LI, 58). Questo aggettivo verrà applicato anche al "testo autorevole" di argomento religioso (matn, dalla stessa radice), divenendo quindi un sinonimo di autorità/autorialità.
laddove il suo Inviato è semplicemente trasmettitore/amplificatore del messaggio.
MUSNAD
Se il Profeta non è (per dogma) autore del Corano, è però anche il primo personaggio storico le cui parole e azioni devono necessariamente essere dichiarate autentiche: il Corano stesso consiglia al buon musulmano di prendere a modello di comportamento la condotta del profeta. I "detti e fatti" di Muhammad devono acquistare, dunque, quei connotati di autorità che risultavano irrilevanti o comunque di relativa importanza per tutti i "portatori di sapere" precedenti.
Il "sapere autoriale/autorevole" di Muhammad verrà conservato con modalità fortemente originali e innovative perfino rispetto al Corano: i "detti e fatti" del profeta (il cui corpus prenderà poi il nome di sunna, tradizione) sono "testi orali", né in versi né in prosa rimata, raccolti e custoditi fedelmente nella memoria dei suoi primi Compagni. Essi sono trasmessi di generazione in generazione attraverso una "catena di trasmettitori" (isnâd) che, a sua volta, deve possedere l'autorità necessaria perché la trasmissione sia considerata valida (sahîh) e degna di fede ("Vera", dunque). In breve, il testo trasmesso (matn) è considerato ininfluente e inaffidabile se non è "appoggiato saldamente" (musnad), ovvero è dotato dello strumento preposto ad accertarne l'autenticità. Questo dispositivo, in cui i due elementi (matn e isnâd) si appoggiano l'uno all'altro, costituisce un nuovo strumento del sapere, il hadîth (racconto, evento, "nuova") che sta alla base del concetto di autorità e autorialità nell'Islâm. Si tratta, anche in questo caso, del prodotto di una cultura orale.
3 - LA SCRITTURA NEI PROCESSI DI FORMAZIONE DELLA CIVILTÀ ARABO-ISLAMICA
All'alba dell'islâm la scrittura è ancora uno strumento di trasmissione del sapere fortemente inadeguato e inadatto alla fissazione inequivocabile di un testo. Essendo l'evoluzione di un alfabeto di tipo aramaico (il nabateo), l'alfabeto arabo contava 21 consonanti, mentre i fonemi consonantici dell'arabo sono 28; come in tutti i sistemi grafici semitici, non vi sono segnate le vocali (se non alcune vocali lunghe e in maniera irregolare); inoltre, dato il suo carattere di corsivo, vi sono numerose consonanti che, legate fra di loro, hanno la stessa identica forma. Di conseguenza, l'ossatura grafica di un testo veniva utilizzata per lo più come una sorta di spartito che desse l'incipit a un qualcosa che già si conosceva a memoria. La composizione letteraria, in definitiva, era ben lungi dal trovare nella forma scritta il suo veicolo di trasmissione. L'introduzione di espedienti ortografici per una registrazione più analitica del testo (punti diacritici, vocali brevi, hamza, shadda, ecc.) è direttamente connessa alla trascrizione della profezia coranica. Solo da quel momento la scrittura, nella sua accezione meramente grafica (khatt), riceve un riflesso della sacralità del Testo Sacro sviluppandosi in tutti in tutte le direzioni.
*Parallelamente si sviluppa in maniera eccezionale anche l'aspetto estetico della scrittura, la calligrafia, la quale sembrerà diventare, nei suoi risvolti artistici, il sostituto iconografico delle immagini umane in tutta l'arte islamica. Non si cada però nell'abbaglio che l'islam debba per questo considerarsi la "civiltà della scrittura" per antonomasia. L'unica scrittura che riveste un ruolo iconico, e dunque sacrale, è quella del Corano: non si troverà un oggetto artistico islamico, mettendo da parte casi rari in ambienti persiani e turchi, recante pezzi di calligrafia che non sia un versetto del Corano.
UMM AL-KITÂB
Il Corano è un vero e proprio "libro orale". Pur essendo stato trasmesso da Dio a Muhammad, e da questi agli arabi, in una forma prettamente orale, esso è già SCRITTO (mastûr, "vergato, tracciato") nella "Madre/Matrice del Libro" (Umm al-Kitâb), cioè una sorta di archetipo increato che rappresenta una scrittura perfetta ed immutabile.
*Uno dei diversi passi coranici in merito recita: "Noi ne facemmo un Corano arabo perché vi sia comprensibile, ed esso, eccelso e sapientissimo, si trova nella Madre del Libro presso di Noi" (Cor. XLIII 3-4). Non ci è dato, ovviamente, conoscere il contenuto e la forma celeste della Madre del Libro, se non attraverso descrizioni di carattere necessariamente metaforico (esso, ad esempio, è "vergato su una pergamena srotolata" dice Cor. LII, 2-3).
L'immutabilità del Corano non consiste nel fatto di essere stato messo per iscritto dagli uomini (come la Bibbia o il Vangelo), bensì nel fatto di essere una composizione divina fedelmente recitata. Ne consegue che il Corano, anche quand'anche assumesse la forma concretamente grafica di un volume, non sarebbe un Libro scritto, bensì "trascritto". L'innovazione nel concetto di "madre del Libro" sta nel suo essere "elaborato a priori", e cioè nell'essere una "composizione" preesistente alla sua trasmissione. Per la prima volta la composizione di un testo letterario è concepita come definitiva e fissata una volta per tutte (e nello specifico perfetta).
KITÂBA
Dal momento che Iddio comanda al suo Inviato di recitare (o tutt'al più leggere) il suo messaggio, Muhammad, durante tutta la sua vita, non si preoccupa di fissare per iscritto la "Recitazione divina". Questa, dunque, essendo soggetta alle regole della trasmissione orale - stante anche la struttura del testo, che non è quella formulare della poesia - rischierebbe di espandersi a dismisura in varianti/aggiunte/elisioni che comprometterebbero l'unicità/univocità, autorialità/autorità del messaggio originario. Ciò di fatto avviene per un certo periodo in cui si producono numerose "letture" del testo (di cui 7 verranno riconosciute ufficiali). Fortunatamente Iddio autorizza la trascrizione del suo messaggio a ché sia ricordato
* <<Chi vuole lo richiami alla mente su pagine sante, eccelse, purissime, con mani di scribi nobili e pie>> (Cor. LXXX, 13-16).
e, così, circa 18 anni dopo la morte del Profeta, il Corano viene trascritto (nella sua forma pressoché definitiva). Per la prima volta in Arabia un'opera di carattere letterario (e non esclusivamente legale/normativo) viene messa per iscritto in un "libro". Ma con "libro" (kitâb), a quel tempo, si intendeva sostanzialmente un registro/indice. Il Corano stesso contiene diversi riferimenti in merito: i libri di cui parla sono quelli in cui sono meticolosamente registrate tutte le azioni umane prima ancora che siano compiute;
* In questa sorta di registro le azioni vengono enumerate (Cor. XXXVIII, 29) e nel <<libro degli empi>> sono annotate ciascuna con un suo numero (Cor. LXXXIII, 7); alla fine dei tempi, il libro <<sarà spalancato>> (Cor. XXXIX, 69) e gli uomini dovranno rendere conto di quanto in esso contenuto.
dunque una "raccolta" o "compilazione" (questa è forse l'origine etimologica del verbo kataba "scrivere") di tipo documentale.
* La funzione meramente legale-amministrativa della scrittura (kitâba) al tempo di Muhammad è descritta con chiarezza nel versetto 282 della sura II (della Vacca): <<O voi che credete, quando contraete un debito a scadenza fissa, scrivetelo (uktubû-hu), e lo scriva (yaktub) fra di voi uno scriba (kâtib) con rettitudine (bi-*adl) e non rifiuti lo scriba di scrivere come Iddio gli ha insegnato; che scriva egli e glie lo detti il debitore [...]. Convocate due testimoni [...] i testimoni quando sono convocati per testimoniare non si rifiutino di farlo; non vi disgusti metter per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, fissandone il termine di scadenza: questa è cosa più giusta presso Dio e più acconcia alla testimonianza e più facile a non farvi venir dubbi. Ma se l'oggetto della transazione è merce pronta che fate girare fra di voi non ci sarà nulla di male se non metterete la cosa per iscritto [...]>>.
Essendo i criteri sottesi alla redazione di questa prima "opera letteraria" vincolati a questa idea di libro, non è un caso che l'ordine in cui le rivelazioni coraniche sono arrangiate sia indipendente dal loro contenuto. In esso non vi è alcun legame cronologico o tematico fra un capitolo (sura) e l'altro (e spesso fra gruppi di versetti nella stessa sura): esclusa la prima sura (la "Aprente") l'ordine dei capitoli è determinato solo dalla loro ampiezza. Alla redazione di tipo archivistico del Corano, inoltre, non soggiace alcuna delle funzioni mnemotecniche in uso nell'Arabia del tempo.
Una delle conseguenze di questa trascrizione e redazione del Corano - ossia nel momento il cui è "Il Libro", a costituire l'autorità fondante di un intero sistema di sapere e di una intera società - è la nobilitazione da un lato del concetto - prima pressoché inesistente - di scrittura intesa come composizione (kitâba), dall'altro del concetto di scrittura intesa come strumento di espressione grafica (khatt). La scrittura divina dell'Umm al-kitâb, infatti, non è collegata con il sistema di scrittura usato dagli uomini e, giacché la "parola" coranica è parte del Libro, mentre la sua scrittura non lo è (o lo è solo nella sua dimensione divina), l'unico collegamento fra i due elementi sta nel dispositivo della "recitazione" (qur'ân). La kitâba, piuttosto, è direttamente connessa al concetto di autorità e di autorialità. Scrivere un testo equivale a fissarlo e renderlo il più possibile immutabile; firmarlo poi (o attribuirlo a un autore "autorevole") significa conferirgli autorità. Insomma: khatt e kitâba divengono un valido strumento di trasmissione del sapere.
Anche grazie a ciò sarà ammissibile, e finanche raccomandabile, scrivere (kataba) la "Biografia del Profeta", o le raccolte di hadîth, o il canzoniere di un poeta, o la narrazione storica degli eventi importanti, o un trattato di grammatica. I primi "libri" scritti in epoca islamica sono per l'appunto la Sîra di Ibn Ishaq, il al-Muwatta' di Malik, le cronache di Abû Mikhnaf che diventano la fonte di Tabarî, i primi trattati di al-Duwâlî.
BIBLIOGRAFIA
Abdallâh, Y. 1988
"Naqsh al-qasîda al-himyariyya aw tarnîmat al-Shams", in Raydan V De Goeje, M. J. 1866
al-Balâdhurî, Ahmad b. Yahyâ (m. 892), Liber expugnationis regionum [Kitâb futûh al-buldân], auctore Imâmo Ahmed ibn Jahja ibn Djâbir al-BelâdsorÌ, quem e codice leidensi et codice Musei brittannici edidit M. J. de Goeje, 2 ed., Lugduni Batavorum, E. J. Brill, 1866.
De Maigret, Alessandro e Avanzini, Alessandra (a cura di) 2000
Yemen, nel paese della Regina di Saba, Milano-Roma Kilito, Abdalfattah c1988
L'autore e i suoi doppi, Torino Monroe, James T. 1972
"Oral Composition in Pre-islamic Poetry", in Journal of Arabic Literature, III Robin, Christian Jules 2001
"Les inscriptions de l'Arabie antique et les etudes arabes", in Arabica, XLVIII Zwettler, Micheal 1978
The Oral Tradition in Classical Arabic Poetry, Columbus
![]()
![]()
Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea
Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte
Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea
Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z
Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9
Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
![]()

